
«Mandate un prete a Pannella, più che andare a trovarlo. In via della Panetteria mandate un sacerdote perché è l’unica persona che può ancora servirgli a qualcosa». Così Camillo Langone, mesi fa, sul leader radicale allora in fin di vita e meta del pellegrinaggio di politici e maggiorenti della cultura e della società italiana. Condivisibile, questa preghiera scritta in marzo: il conforto ultimo serve a tutti e non si nega a nessuno. Perché iniziare da Pannella, volendo recensire “Pensieri del lambrusco. Contro l’invasione”, l’ultimo libro di Langone edito da Marsilio, è presto detto: come il vecchio leone dalle cravatte fiorite anche l’autore potentino naturalizzato parmense fa di tutto per farsi odiare ma viene salvato dalla sua arte. Che in Pannella era la retorica variopinta e l’inusuale potenza dei discorsi a braccio; in Langone è lo stile perfetto di una penna viziosa, orgogliosa di molto bere e molto detestare, molto bere e molto resistere. Ora non so quale possa essere la reazione di Langone a questo parallelismo: a mia discolpa dirò che scrivo previa autorizzazione, avendogli chiesto il permesso ed avendolo ricevuto durante una ricca conversazione. «Congratulazioni per il tuo nuovo libro. Posso chiedere all’editore una copia per recensirlo?». Risposta: «Fallo». Nel dubbio tra avere ricevuto un assenso o un cartellino rosso la richiesi ugualmente. Arrivò, lessi, mi piacque. La scrittura, punto il contenuto. Lo stile, punto lo sciovinismo incomparabile dell’autore, e questi sono tutti complimenti prima di essere critiche, in quanto che egli di non piacere e di essere sciovinista si compiace non meno che del lambrusco che dà titolo al libro (ispiratissimo vino, è vero).
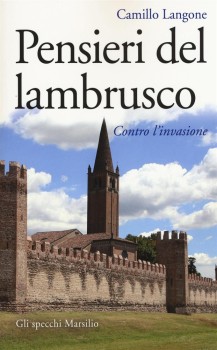
La copertina del libro “Pensieri del lambrusco. Contro l’invasione”, edito da Marsilio.
«Vidi la patria invasa e mi rifugiai nel lambrusco. Ero troppo esperto di vini per poter cercare conforto a un’invasione nel cabernet o nello chardonnay, dozzinali vitigni alloctoni. Scelsi il lambrusco siccome unico vero vino autoctono italiano, derivante non dalle viti caucasiche portate dai greci ma dalla vite selvatica presente ben prima della storia nella foresta primaria padana». Così l’introduzione al volume che è una raccolta di “Preghiere”, la quotidiana rubrica che Langone tiene sul Foglio e per la quale tocca ringraziare Giuliano Ferrara. C’è dentro tutto l’universo mondo: raccolte per tema, esse si dipanano con la continuità di una litania, nella cui contemplazione il vino ha un ruolo marginale, lasciando spazio ad un Ego che non permette comprimari, né parlando di società né di cultura né di politica né degli infiniti gangli della critica langoniana che è assoluta e non si aggrappa a nulla se non – dice lui – alla bottiglia. Una volta compreso il sistema – l’organicità del pensiero, per le prime pagine, dà persino l’idea di un saggio strutturato – il lettore si può avventurare a suo rischio e pericolo: perché arriveranno momenti di depressione, a leggere certe cose, poi scatti di rabbia e desiderio di violenza, poi estasi mistica se non fosse alcolica; ma sempre il piacere di una scrittura ferma e tempestosa, qualcosa di simile, per chi ha fatto l’esperienza, al versare del mercurio e vederlo colare e poi fermarsi nella sua immobilità di metallo. Ma se la recensione è un esame critico non vorrei mancare di palesare al lettore proprio la critica: dopo aver detto della piacevolezza dirò dunque dell’inconsistenza della tesi di fondo, ossia dell’invasione. Tanto l’assenso dell’autore credo d’essermelo giocato sin dalla prima riga.
Invasione, lui dice: e benché sia del tutto legittimo per chiunque dare alle parole il senso che vuole, la lingua italiana dà a quel termine un significato preciso che è bene ribadire. La Treccani mi dice che l’invasione è «l’ingresso nel territorio di uno stato da parte delle forze armate [corsivo nel testo, ndr] di uno stato belligerante, per compiervi operazioni belliche, con o senza l’intenzione di occuparlo»; «con riferimento soprattutto alla storia medievale, la penetrazione in un territorio di popoli che migrano in cerca di nuove sedi»; «irruzione violenta o arbitraria di persone in un luogo». Nessuno di questi tre significati sembrerebbe descrivere l’attuale situazione italiana: se non forse il secondo, ma è lo stesso Langone a dirci che l’accostamento è macchinoso: «Stavo leggendo un bel libro di Bryan Ward-Perkins, storico di Oxford, intitolato La caduta di Roma e la fine della civiltà. Stavo cercando di trovare i nessi tra l’invasione presente e le invasioni barbariche del quinto secolo. Faticavo a trovarle. Poi però lessi che il giornalista Magdi Cristiano Allam era stato messo sotto processo dall’ordine nazionale dei giornalisti con l’accusa di islamofobia. Allora riguardai l’indice del libro di Ward-Perkins ed eccolo il nesso. Nel titolo di un capitolo: “La vita sotto i nuovi padroni”». Faticava, e fin qui lo seguivo faticando anch’io: poi il riferimento al “padrone” tradisce il pregiudizio tradendo anche i significati della Treccani: non c’è volontà di sopraffazione da parte delle masse stremate che ripopolano i mari italiani come al tempo dell’ultima Guerra. Il discorso si fa complicato, perché l’autore non segna confini netti tra invasione e immigrazione, tra islam e islamismo – forse perché in lui questi concetti coincidono perfettamente: ma mi diceva Diego Fusaro che è il Padrone per eccellenza, ovvero il Capitale, a volere queste masse come esercito industriale di riserva; e ce lo dice anche il Papa, cosicché il riferimento di Langone al “padrone” è forse giusto ma indirizzato alle persone sbagliate, se invasore e padrone ritiene ognuno dei disperati che sbarca in Italia e in Europa.

La versione della recensione apparsa su “La Croce – Quotidiano”
Ma se la ponessi soltanto così starei imbrogliando. Langone affronta il tema dell’invasione in senso lato, in quello cioè che ancora la Treccani, «in relazione ai significati estensivi e figurativi di invadere», definisce «qualsiasi cosa che irrompa in un luogo occupandolo o diffondendovisi in gran quantità: un’invasione di cavallette, di topi; arginare l’invasione delle acque; l’invasione del morbo, di un’epidemia; c’è un’invasione di prodotti (o anche di cantanti) stranieri, di film polizieschi, di fumetti pornografici». Ecco il senso, infine, di ciò da cui l’autore della Preghiera vuole difendersi: l’invasione di mondi altri che giungono nel nostro e giocoforza, stanti le attuali condizioni, lo piegheranno; la fatale connivenza di molti italiani, di cui non si sente concittadino, con questa dinamica inesorabile che ha come meta finale l’estensione. Così l’invasione di prodotti alimentari extraitaliani sulle tavole imbandite dei superficiali, quella dei centri commerciali nel diritto al riposo dei loro impiegati, quella del femminismo di maniera nella femminilità vilipesa delle donne occidentali sono per lui il senso di quell’invadere che un po’ superficialmente attribuisce indistintamente a profughi e terroristi, a islamici e islamisti. E qui si potrebbe ancora una volta seguirlo, se il modo volutamente estremo di dire cose in teoria condivisibili non pervadesse queste pagine, e se chi le ha scritte non volesse mantenere il distacco da tutto e tutti al punto da non volere nemmeno organizzare presentazioni dell’opera (gustosissimo a tal proposito un suo post su Facebook, ove parla sempre in terza persona: «Visto che molti chiedono le date delle sue presentazioni, e visto che si vocifera di presentazioni a San Benedetto del Tronto e a Soragna (mai nemmeno ipotizzate), è costretto a ricordare che di “Pensieri del lambrusco” NON sono previste presentazioni. Perché la presentazione è un rito penoso, a misura di autori vanesi e di non lettori. Ovviamente se un organizzatore offrisse una busta di contanti, una platea plaudente, un palco senza moderatori, un’ora da dedicare alla nuda lettura senza domande finali, si potrebbe pensare a un’eccezione, che verrebbe qui comunicata». Offritegli ciò che chiede, su!).
Invasione latu sensu, dunque. Il lambrusco come rifugio, ma prima di esso, per fortuna, il cristianesimo. Che si prende la briga di difendere – cita diverse volte anche il papa, e quasi sempre in positivo, il che lo rende trasgressivo nei confronti dei cattolici integralisti che trasgressivi vorrebbero essere – spiegando perché, nella sua logica incomprensibile e pertanto di ferro, non sia di esso la colpa di ciò che sta accadendo. «Bisognava smetterla di addebitare al cristianesimo l’infatuazione per i profughi [sic!] da parte di atei e cardinali (categorie che a volte coincidevano, come ricordava spesso padre Amorth). In qualità di uomo invaso non potevo sopportare che Gesù fosse ridotto a precedente dei politici entusiasti di invasioni, pavoni dell’irrealtà. Nel Vangelo l’amore era un singolo, non un continente (don Milani lo aveva capito meglio del cardinale Bagnasco: «Chi ama veramente Dio, ama solo poche persone»). Nel Vangelo l’amore era chiesto da Dio, non imposto da Cesare: non vi si adombrava in alcun modo la vigente dittatura dell’altruismo. Nel Vangelo il buon samaritano pagava il locandiere perché si prendesse cura del ferito, non pretendeva che lo ospitasse a sue spese. Nemmeno nel Vangelo esistevano pasti gratis, salvo quelli allestiti da Gesù in persona. Chi non essendo figlio di Dio si comportava come se fosse umanamente possibile moltiplicare pani e pesci era un falso profeta e un assoluto cialtrone». Anche qui, come trovare la chiave giusta per condividere ciò che di buono c’è – non si possono moltiplicare pani e pesci – da ciò che sembra meno supportato teologicamente? In questo campo non mi avventuro, essendoci in forza a questo giornale figure più idonee alla risoluzione dell’infinita serie di enigmi concentrati da Langone in una decina di righe. Il cristianesimo sarebbe in sostanza giustificato in quanto assiomaticamente ostile al concetto di amore universale, il che è esattamente il contrario di ciò che ci dice il papa quotidianamente; ovvero, a braccio, che la poca universalità dell’amore cristiano è una colpa, in quanto «i rifugiati sono persone come tutti, alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a rinnovare l’impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro: incontrarli, accoglierli, ascoltarli, per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà di Dio». (Angelus, 19.06.2016).

Un ritratto ad olio di Camillo Langone
Chi ascolteremo, Langone o il papa? E’ una domanda che ci siamo già posti con altre figure, con scrittori cattolici impazziti e blogger cattolici pazzotici, ogni volta che al papa venivano accuse durissime e finanche di eresia, vette di imbecillità con le quali Langone non è minimamente in gara. Posta infine la legittimità della questione – dell’invasione come concetto universale e non strettamente geopolitico –, quale sarà il modo giusto di affrontarla? E soprattutto, porsi con nettezza da una parte o dall’altra senza rinchiudersi nel proprio guscio di ignavia può essere considerato un viatico per la salvezza? A questo punto occorre dire che queste considerazioni emergono sì da “Pensieri del Lambrusco” ma non ne sono il senso ultimo: in quanto a leggerlo, il libro, non ci si avvede più di tanto della scelta di vita cristiana dell’autore. Non c’è alcun dubbio che egli cristiano si professi, ma ha la gradevolezza di scrivere in modo da non darne troppo avviso, componendo quello che alla fine è un agile trattatello di società, un gradevole zibaldone di tante cose e tutte affrontate con abbastanza specificità (quella che non ci sembra tale l’abbiamo detta per prima). Così leggeremo a distanza di pochi fogli di alimentazione e grattacieli, di omosessualismo e centri commerciali, di cani (che sembra odiare) e femministe esasperate che chiama genialmente «uome», e qui non si può che indirizzare a Langone un pensiero di bene, che gli ci vuole. Ma sarà interessante notare come lui, scrivente sul Foglio, segua Mario Adinolfi e apprezzi Costanza Miriano; e come non legga questo giornale, con la seguente dottissima motivazione: «Dicevo a un amico che un quotidiano cattolico è una contraddizione in termini: katholicòs in greco vuol dire universale, ridurre il cristianesimo ad una specializzazione significa negarlo. E quindi dicevo all’amico che mi guardavo bene dal leggere “Avvenire”. Non leggevo nemmeno “La Croce”, dove pur scrivevano veri credenti: era comunque l’organo di un gruppo e io tendevo all’ecumenico e con Gesù pregavo “perché tutti siano una cosa sola”». La Preghiera continua con una critica ad “Avvenire” che potrete andarvi a leggere comprando il libro: il costo è anche abbastanza ridotto.
Così lui si rifugiava nel vino e lasciava a noi il rovello di che cosa pensare – buon per noi, perché significa essere pensanti. Si discuteva con un amico di quanto la prosa di Langone avrebbe potuto essere migliore se migliori fossero state le sue intenzioni: se ciò non ci avesse tenuto in modo così ossessivo ad essere altro rispetto agli altri. Perché in fondo è pur sempre uno scrittore e un giornalista, nonostante si fregi di avere inventato la figura del “critico liturgico”, e uno che di scrittura campa dovrebbe, bene o male, accettare il fatto di essere letto e apprezzato. E non c’è diminuzione di talento, carenza di contenuti, discrimine alla santità nel fatto che qualcuno si trovi d’accordo con un altro senza che questi debba necessariamente bastonarlo. Ma Dio è perfetto e lo si capisce quando l’umanità di Langone, nonostante Langone, viene a galla; quando dopo aver scritto cose piuttosto forti sulle donne e la femminilità si scopre languido come un giovane amante; quando scrive di avere il cuore straziato per le sepolture di ragazzi giovani, o per i nomi dei vecchi che non sentirà pronunciare più; o quando, a proposito della morte e dei suoi insegnamenti, scrive “di una generazione senza più novembre”. C’è poesia in queste righe deliberatamente cattive e fintamente antipatiche; c’è poesia e c’è arte e tutto un mestiere dimenticato dagli uomini che è quello di bene scrivere per bene indicare al mondo che cosa un uomo, nella sua pochezza, è stato. E’ la grazia di poter dire cose sbagliate – non sta a me giudicarlo – in modo bello: «C’erano state nel corso del tempo invasioni numerose, tutte tragiche ma nessuna culturalmente esiziale perché nel passato gli aggressori dopo le vittorie militari dovevano vedersela con una Chiesa salda nella sua fede, con un popolo solido nel suo buonsenso, con contadini forti nella loro autarchia, con madri fondate nella loro natura, mentre all’inizio del ventunesimo secolo gli attacchi portati alla lingua e alla religione, ai campanili e ai presepi, alla domenica e ai bambini, ai poeti e ai salumi, entravano come coltelli nel burro tiepido. Vidi il cuore dell’Italia vuoto per apostasia, le vene dell’Italia vuote per crollo demografico, e prima che la deculturazione riducesse i miei connazionali a indiani nelle riserve, abbrutiti dal paternalismo di nuovi padroni, provai, incoraggiato dal vino,a riempire di parole una parte di quel vuoto».










