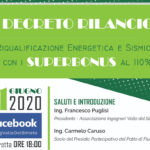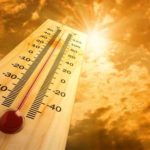Photo: Andrea Piacquadio
Se la parola costituisce la base dell’umanità stessa e della cultura, si potrebbe dire che la scrittura è davvero la lingua della mano. Con la sua sobria eleganza e chiara leggibilità, il corsivo è a tutti gli effetti un’espressione artistica del proprio sé, una sua rappresentazione nero su bianco. Dal latino currere (che corre, che scorre), il corsivo compare per la prima volta nel Rinascimento – a seguito della pubblicazione delle Epistole di Caterina da Siena nel 1500 – come risposta al tentativo di economizzare il tempo impiegato a riempire la pagina. Questo spinge il tipografo Francesco Griffo a realizzare uno stile veloce, compatto, raffinato e di facile decifrabilità. L’introduzione di questo carattere ha inciso sul mondo culturale dell’epoca, tanto che all’estero si parla di “italico”: si tratta di un segno in grado di riproporre la scrittura morbida tipica degli amanuensi, inclinata verso destra, e con le lettere legate tra loro in maniera continua. A differenza dell’allora carattere in voga – poco adatto al gusto degli umanisti dediti alla lettura meditativa – fatto di lettere distaccate tra loro, il corsivo consente la produzione di un maggior numero di libri in formato ridotto, in virtù dello spazio ristretto occupato dal simbolo nella pagina, a scapito di quello tondo, che domina la stampa del XV secolo; ne deriva una scrittura veloce e personalizzata, che si diffonde su scala internazionale a partire dal Cinquecento.
In alcuni paesi lo si apprende fin dalla scuola materna, in altri è stato abolito in favore dello stampatello, come in Messico: è il caso della Finlandia, che a partire dal 2016 ha eliminato l’obbligo di imparare a scrivere con carta e penna. Fortunatamente, in altre nazioni più conservatrici è ancora in auge; in Francia lo si apprende a partire dall’asilo, in Italia i bambini familiarizzano con esso dalla prima elementare, eccezion fatta per quelli che presentano un disturbo dell’apprendimento. Il corsivo è parte integrante della nostra storia, un mezzo di farci percepire l’attaccamento alle nostre radici; persino negli Stati Uniti, che nel 2009 lo avevano eliminato, è stato reintrodotto.
La psicologia e la pedagogia concordano nell’asserire che la scrittura a mano tradizionale aiuta i bambini a sviluppare abilità motorie e ad affinare le funzioni intellettive. Tanto per cominciare, potenzia la relazione tra la mano e il cervello, tramite l’attivazione di circuiti nervosi preposti a favorire lettura, memorizzazione, produzione di parole. Inoltre, stimola lo sviluppo delle abilità manuali e visuo-spaziali, contribuendo ad allenare il pensiero logico-lineare: la sequenzialità delle parole si traduce in sequenzialità del pensiero, consentendo al piccolo di migliorare le competenze analitiche e sintetiche in rapida sequenza. Non solo: il bambino scopre il piacere della scrittura grazie allo sviluppo di un tratto grafico personalizzato e originale, che diventa la marca della propria interiorità. E per finire, la pratica del corsivo – con il suo scorrere da sinistra a destra – consente l’acquisizione di competenze basilari di ordine cognitivo e psicomotorio, quali flessibilità e fluidità.
Eppure, in Italia un bambino su cinque non sa scrivere in corsivo. A dirlo, un team di ricercatori del Policlinico Umberto Primo e dell’Università Sapienza di Roma, che, nel tentativo di identificare eventuali patologie ostacolanti per l’apprendimento fino alla soglia dei dieci anni ha condotto uno studio sulla leggibilità della scrittura nei bimbi romani, da cui è emerso un dato allarmante: il 21,6% di loro è a rischio di sviluppare un problema di scrittura. E un 10% ha una scrittura “disgrafica”. Indubbiamente l’uso massivo di pc, tablet e cellulari ha abituato l’occhio alla praticità dei caratteri dello stampatello, che domina gli schermi; caratteri che si ritrovano all’interno dei manuali scolastici, a conferma del fatto che – come ci suggerisce l’etimologia – lo stampatello nasce per essere letto, il corsivo per essere scritto.
C’è chi poca responsabilità attribuisce a tablet e smartphone, soffermandosi sull’inefficacia di certi metodi di insegnamento: è il caso del metodo globale, ben lontano da quello fono-lessicale (che prevede la sillabazione in fase di alfabetizzazione), in nome di un approccio olistico della parola, che non viene scomposta in elementi primitivi ma presentata nella sua globalità attraverso un’immagine. Lo stesso avviene per la fase di scrittura: ai bambini non viene suggerito alcun percorso efficace ed economico per ogni lettera tracciata, ma è il bimbo a trovare autonomamente il percorso di tracciatura a lui conveniente, benché talvolta più dispendioso. Ora, l’assenza di linee guida ministeriali circa i metodi di apprendimento e insegnamento ha dato vita a un dibattito che non vede l’unanimità delle parti implicate, tanti sono i dubbi e le criticità sollevati dalle autorità competenti. Certamente, il corsivo si deve amare, inseguire, lavorare con minuziosità.
Di sicuro, le moderne tecnologie hanno comportato una riduzione di tempi e costi, grazie all’ausilio di software dotati di riconoscimento vocale che hanno rimpiazzato la scrittura a mano; questi dispositivi consentono addirittura di spostarsi abilmente sulla tastiera, indietreggiando o cancellando il tratto con un semplice click, rimuovendo definitivamente ogni traccia del segno, seppur digitale. Nella scrittura corsiva, ogni parola ha un ruolo e il margine di errore è minimo, proprio in virtù del flusso continuo e privo di interruzioni tipico dello stile italico.
Niente è in grado di organizzare pensieri, idee, appunti, informazioni come il gesto dello scrivere: è proprio il gesto della mano ad assicurare quella connessione tra parola scritta e pensata, estranea alla digitazione su tastiera; non a caso, il gesto scritto permette il ripristino di alcune funzionalità perse, relegando la scrittura a un ruolo di grande valore per la crescita individuale. E, se la concretizzazione di un’idea trasposta su un foglio è vitale, terapeutica, catartica, salvifica, allora è proprio il caso di dire che la scrittura è davvero la lingua della mano.